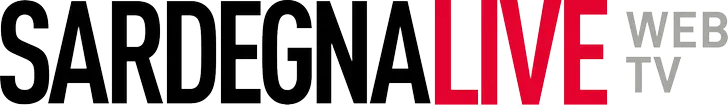PHOTO
In Italia si stima che circa 2,8 milioni di persone sopra i 15 anni abbiano sofferto di depressione (ISTAT 2018) e la Sardegna detiene il triste primato di essere la regione con il tasso di suicidi più alto del Paese. Un dato che, soprattutto tra i più giovani, desta crescente preoccupazione.
Nello specifico, secondo i dati forniti dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità) e pubblicati nel 2011, l’Isola si trova al primo posto per il numero di suicidi annui: 11,4 ogni 100.000 abitanti (dai 14 anni in su), mentre i numeri nazionali risultano in linea o addirittura inferiori rispetto alla media degli altri Paesi europei.
I dati ISTAT del 2022 analogamente descrivono un fenomeno sempre più in crescita, 3.934 suicidi registrati nel corso dell’anno, inoltre, nel biennio 2021/2022 è stato riscontrato un tasso di 0,40 suicidi ogni 10mila abitanti, il numero più alto osservato dal 2015.
Per comprendere meglio il fenomeno, abbiamo parlato con la dottoressa Elisa Cantone, laureata in Psicologia con specializzazione in psicoterapia analitica transazionale, libera professionista e collaboratrice dell’Università di Cagliari, sia presso il Centro di Psichiatria e Psicosomatica dell’ospedale San Giovanni di Dio, sia come docente nel corso di laurea in Educazione professionale.
“La depressione è un fenomeno complesso: contano fattori geografici e sociali, come l’isolamento dei piccoli paesi, unito alla difficoltà di accedere tempestivamente ai servizi di salute mentale. C’è sempre un intreccio di più elementi, non una sola causa”, spiega Cantone.
L’abbiamo poi interrogata sulle ragioni che possono spingere una persona a togliersi la vita.
“Alla base ci sono spesso disturbi psichiatrici, ma pesano molto anche eventi dolorosi come lutti, separazioni, problemi economici e situazioni di isolamento. Alla fine, la persona si sente senza via di uscita e l’unica soluzione che riesce a immaginare è la morte.”
A preoccupare è anche l’impatto crescente sulla popolazione più giovane: sempre più adolescenti mostrano sintomi di depressione.
“Sì, questo numero è in crescita. Incidono la pressione scolastica e lavorativa, la precarietà del futuro e, negli ultimi anni, gli effetti della pandemia. Quest’ultima ha creato situazioni di isolamento profondo: i ragazzi si sentivano connessi attraverso i social, ma in realtà erano soli.”
Ma cosa si può fare nella quotidianità se si pensa che un amico o un familiare stia affrontando uno o più di queste problematiche?
“È fondamentale osservare i segnali: isolamento improvviso, frasi di disperazione, cambiamenti di umore. Bisogna parlarne apertamente, senza paura di nominare il problema, mostrare vicinanza con gesti quotidiani e, se necessario, accompagnare la persona a chiedere aiuto.”
Affidarsi a professionisti è fondamentale, ma ancora oggi molte persone hanno difficoltà a farlo?
“Sì, lo stigma è ancora forte: molte persone temono di essere giudicate se parlano della propria sofferenza. Negli ultimi anni lo Stato ha introdotto strumenti come il bonus psicologico, che ha permesso a molti di accedere a percorsi di supporto. Tuttavia, i fondi per la salute mentale restano limitati e, nel privato, i costi continuano a essere troppo elevati.”
Negli ultimi anni da parte dello Stato sono stati fatti diversi passi avanti, come campagne di sensibilizzazione, finanziamenti regionali e il già citato bonus psicologo, ma il fenomeno resta in crescita. Cosa si può fare ancora?
“Bisogna potenziare i servizi di salute mentale sul territorio e rendere la psicoterapia accessibile a tutti, come diritto e non come privilegio. Inoltre, è fondamentale il passaparola: qui in Sardegna esistono centri di salute mentale che operano attivamente per il benessere dei cittadini.”