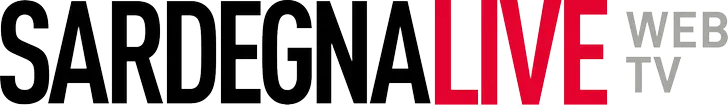PHOTO
La riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri ha ottenuto l’ok definitivo dal Senato, tra le proteste compatte delle opposizioni. Con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni, il Parlamento ha chiuso il suo quarto e ultimo passaggio, ma senza raggiungere la maggioranza dei due terzi necessaria per evitare il referendum confermativo. La consultazione popolare, quindi, si farà — con ogni probabilità nella primavera del 2026 — e la maggioranza ha già avviato le procedure per richiederla.
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha espresso soddisfazione per l’esito del voto: «Ringrazio il Parlamento. La maggioranza è stata ottima. Sono trent’anni che scrivo sulla separazione delle carriere. Mi auguro ora che sul referendum ci siano termini pacati, che non sia politicizzato».
Una magistratura, due percorsi distinti
Il cuore della riforma è la netta distinzione tra le funzioni requirenti e giudicanti. I magistrati, all’inizio della loro carriera, dovranno scegliere in modo definitivo se diventare giudici o pubblici ministeri. All’articolo 104 della Costituzione, che già sancisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura da ogni altro potere, viene aggiunta la specificazione che essa è composta da due carriere separate.
Due Consigli superiori e la scelta per sorteggio
L’attuale Consiglio superiore della magistratura sarà sostituito da due organi: uno per i giudici e uno per i pm. Entrambi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica e comprenderanno di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione.
I nuovi Consigli non saranno elettivi ma formati tramite sorteggio: un terzo dei membri sarà scelto tra giuristi designati dal Parlamento, mentre i restanti due terzi saranno estratti a sorte tra magistrati in possesso dei requisiti che saranno definiti da una legge ordinaria. Il mandato durerà quattro anni, senza possibilità di rinnovo immediato.
Nasce l’Alta Corte disciplinare
Le funzioni disciplinari, oggi affidate a una sezione del Csm, passeranno a un nuovo organo: l’Alta Corte disciplinare. Sarà composta da 15 membri, in parte nominati dal Capo dello Stato e in parte sorteggiati tra giuristi e magistrati con almeno vent’anni di servizio ed esperienza in Cassazione. Pur essendo i togati in maggioranza, la presidenza spetterà a un laico. Le sentenze potranno essere impugnate solo davanti alla stessa Corte, che giudicherà in diversa composizione: non sarà possibile ricorrere in Cassazione.
Le leggi attuative e il referendum
Entro un anno dall’entrata in vigore — quindi dopo l’eventuale referendum — dovranno essere approvate le leggi attuative che definiranno nel dettaglio il funzionamento dei nuovi organi.
Non avendo raggiunto il quorum dei due terzi in entrambe le Camere, la riforma potrà essere sottoposta a referendum confermativo, come previsto dall’articolo 138 della Costituzione. A chiederlo potranno essere un quinto dei parlamentari, 500mila elettori o cinque Consigli regionali. A differenza del referendum abrogativo, quello costituzionale non richiede il quorum del 50% degli aventi diritto.