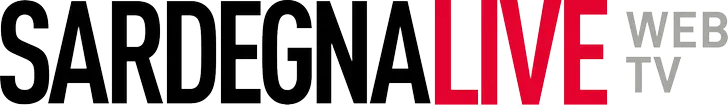PHOTO
La storia della Sardegna medievale si configura in maniera del tutto singolare rispetto al resto dello Stivale. L'Isola, sin dall'alba dei tempi considerata punto strategico di vitale importanza nel dominio del Mediterraneo, a partire dal crollo dell'autorità bizantina (VIII-IX secolo), vide svilupparsi una forma di organizzazione politica autonoma e peculiare: i giudicati.
Contesto e successioni storiche
Così, in quattro macro aree, si configurarono altrettanti regni indipendenti, ciascuno guidato da un sovrano chiamato judike (da qui il nome giudicati): Cagliari, Torres (o Logudoro), Arborea e Gallura. Come erano organizzati? L'assetto era abbastanza moderno, considerando l'epoca: suddivisi in circoscrizioni (curatorie), disponevano di assemblee rappresentative (le coronas de curatoria), di un’amministrazione territoriale stabile e di una legislazione autonoma. Non si trattava di semplici feudi, ma di vere entità statali.
Dall'XI secolo ricaddero pesanti e invasive attenzioni sull'Isola da parte delle grandi potenze marinare, con Genova e Pisa in prima fila, che avevano capito l'importanza di un'eventuale supremazia sui traffici mediterranei e di un controllo dei porti sardi. I pisani si insediarono nel sud e nel centro Sardegna, mentre i liguri, con a capo la potente famiglia dei Doria, concentrarono le attenzioni sui territori della Gallura e dell’Anglona. A partire dal XIV secolo la Sardegna entrò nell’orbita della Corona d’Aragona, quando dopo una lunga campagna militare divenne parte integrante della monarchia iberica, diventando Regno di Sardegna e Corsica, istituito nel 1297 dal Papa Bonifacio VIII e concesso come feudo a Giacomo II d'Aragona.
Nonostante i tentativi di resistenza, affidati a figure di spicco come Mariano IV, Ugone III ed Eleonora d’Arborea, la battaglia di Sanluri (1409) decretò il definitivo cedimento e la Sardegna restò sotto dominio aragonese e poi spagnolo fino al XVIII secolo. In questo lasso di tempo numerose famiglie presero parte ai giochi di potere che interessarono il frammentato territorio isolano. Se nei primi tre-quattro secoli la scena fu dominata dalle dinastie locali dei quattro giudicati, successivamente si assistette al graduale insediamento delle potenti famiglie provenienti dal nord della penisola: i Malaspina nel Logudoro e a Bosa, i Doria in Gallura e nell’Anglona, i Visconti di Gallura nel nord-est, i Della Gherardesca nel Cagliaritano. Poi, come già detto, queste lasciarono spazio al dominio aragonese.
Ancora oggi le testimonianze di quell'epoca intensa e tormentata vivono nel segno delle imponenti opere sopravvissute al logorio del tempo ed eco di un'intensa storia di successioni e dominazioni: castelli e fortezze, chiese e basiliche, torri, bastioni e centri urbani.
Il Castello di Osilo
Una di queste è il Castello di Osilo, uno dei luoghi più suggestivi e significativi della storia medievale sarda, di cui oggi si conservano soltanto i ruderi. Fu roccaforte di vitale importanza strategica, insediata a circa 600 metri di altezza sul livello del mare, sul monte Tuffudesu, che ne faceva un punto di osservazione privilegiato. Dal castello era infatti possibile dominare con lo sguardo gran parte del territorio circostante, fino al Golfo dell’Asinara. La prima attestazione risale al XII secolo, quando l'area apparteneva al Giudicato di Torres.
Nel secolo successivo, tuttavia, la fortezza passò sotto il controllo dei Malaspina, nobile famiglia toscana proveniente dalla Lunigiana. Gli occupatori ne fecero una vera roccaforte feudale, potenziandone la struttura e rendendola parte di un più ampio sistema di fortificazioni. Da quel momento, le vicende del Castello di Osilo andranno di pari passo con quelle della Sardegna. Anche gli aragonesi intuirono subito l'importanza di quell'area come viatico per traffici e comunicazioni, rendendolo così un importante punto strategico-militare. Altresì, il passaggio sotto il dominio della corona iberica ne segnò gradualmente il declino. Il mutare delle dinamiche di potere, il rapido progresso nell'ingegneria bellica e lo spostamento dei centri d'interesse verso le città costiere ne segnarono il graduale abbandono.
Testimone di storia
Ciò che oggi ne rimane, consente soltanto una parziale ricostruzione di quel che fu la fortezza osilese. La pianta era irregolare, adattata all’orografia del terreno, con una cinta muraria che abbracciava le sommità del colle e almeno una torre principale, probabilmente un mastio, destinata a funzioni di avvistamento e di difesa estrema. La struttura interna si suddivideva in ambienti residenziali e di servizio, magazzini e spazi destinati alle guarnigioni. Le mura, costruite con pietre locali, più che rappresentare una dimostrazione di sfarzo dovevano trasmettere un senso di solidità, considerate le finalità prettamente difensive della struttura.
Nonostante di esso non rimangano che ruderi, la fortezza conserva un valore simbolico e una testimonianza da preservare. Come ogni opera, infatti, racconta il succedersi di vicende storiche e politiche che hanno stravolto le sorti di uno dei territori più contesi dalle potenze nazionali e straniere nella storia d'Italia. E così, la storia del Castello di Osilo diviene parabola di quella isolana nel Medioevo, attraversando tutte le fasi più intense: dal potere locale a quello nazionale, fino all'occupazione estera; dalla crescita al consolidamento, fino al decadimento e all'abbandono, prima del recupero e del riconoscimento storico e culturale che oggi lo rende patrimonio identitario del Logudoro e della Sardegna.